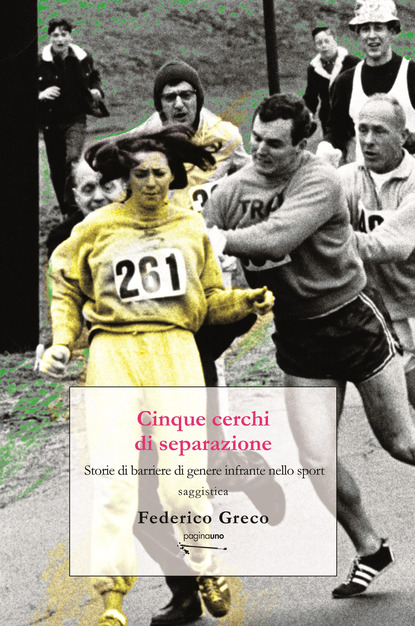Il 15 giugno del 1946 è un giorno importante per il ciclismo nostrano perché riparte il Giro d’ Italia. Sono passati sei anni da quando Milano aveva festeggiato Fausto Coppi e di mezzo c’è stata la Seconda guerra mondiale.
Scrive la Gazzetta dello Sport in prima pagina, in alto a sinistra:
Napoletani e torinesi, lombardi e laziali, veneti ed emiliani, gli italiani tutti, tante regioni per un’unica civiltà e un unico cuore, attendono nel Giro lo specchio nel quale riconoscersi e sorridersi.
È fausto che questo privilegio sia assegnato allo sport.
Non c’è la firma, ma è un editoriale e si può ben immaginare che dietro queste parole ci sia la penna del direttore Bruno Roghi, che già aveva ricoperto quel ruolo dall’ottobre del 1936 all’8 settembre 1943 (quindi, in pieno Fascismo e fino al giorno dell’Armistizio) e che, non a caso, parla di «guerra perduta» in riferimento al conflitto che ha avuto come conseguenza la caduta del regime di Mussolini.
Quindi, sorprende poco che chi, come Roghi, ha ripreso il suo posto -nonostante i fascisti non siano più al potere-, spera che la corsa in partenza da Milano aiuti a normalizzare, a distrarre, a far dimenticare, senza tematizzare troppo. Ad ogni modo, sono ancora di là da venire i giorni in cui anche i Coppi e i Bartali saranno coinvolti in narrazioni politiche, specchio delle lotte sociali che attraverseranno la penisola nei primi decenni del Dopoguerra.
Per ora, ancor più importante per la Gazzetta, che del Giro è anche organizzatrice, è far fronte a un’altra eredità della guerra: l’indigenza, la miseria in cui versano milioni di famiglie. Il Giro è, infatti, una «”corsa del popolo”» anche perché sono di estrazione popolare molti dei partecipanti che possono sì e no ambire a una vittoria di tappa e vedono nello sport della bicicletta un modo per mettere da parte qualcosa. D’altro canto, anche lo stesso quotidiano sportivo ha bisogno di soldi e sponsor per rimetter su la grande macchina del Giro e, a loro volta, piccoli e medi imprenditori delle varie parti d’Italia hanno interesse a farsi della pubblicità attraverso la corsa ciclistica. Insomma, se i premi speciali riservati ai corridori sono davvero variegati e anche un po’ fantasiosi, più di un motivo c’è.
Ad esempio, chi vincerà la tappa di Roma, riceverà in dono una bicicletta Covolo; chi lo farà a Bologna, una cassetta di liquori Buton; chi arriverà primo nella frazione che passa per Montecatini e Prato, dei copertoni Albatros. Un rasoio Raselet Ducati andrà, invece, a Torino sia al primo assoluto che al primo della classifica riservata agli “aggruppati”, sorta di ciclisti indipendenti tesserati per le polisportive e non per le squadre ufficiali. Il premio vincitore solitario andrà poi a tutti coloro che arriveranno da soli con almeno un minuto di vantaggio: non è specificato l’importo, ma per i carneadi amanti delle fughe è di sicuro un incentivo.
Ci sono poi i premi al merito (probabilmente soldi) per chi si metterà in mostra in tappe singole, pur senza vincerle, e i premi per le vedette dei gruppi, riservato ai primi a fine Giro di ciascuno dei sei gruppi in cui sono divisi gli “aggruppati”. Un dollaro al giorno, quindi, un dollaro in ogni tappa, andrà al corridore più sfortunato della frazione appena conclusa, mentre il premio del numero “13” verrà estratto a sorte a fine Giro tra tutti coloro che si classificano tredicesimi nelle varie tappe.
Il quotidiano comunista L’Unità guarda, infine, agli esordienti: ai primi tre di ogni tappa, rispettivamente, 1000 ₤, 500 ₤ e 250 ₤ 1 e 5000 ₤ al miglior esordiente in classifica a fine Giro. L’interesse dell’organo del PCI per la «rinascita dello sport popolare» non deve sorprendere: in gara c’è anche il gruppo Fronte della Gioventù, chiaro riferimento all’organizzazione giovanile partigiana attiva durante la Resistenza.
Molto più indicativo della realtà sociale in cui il Giro del 1946 si innesta è, però, il lettino offerto in premio per il primo corridore che diventerà papà nel corso della manifestazione o subito dopo. Indicativo perché lega implicitamente rinascita post-bellica dell’Italia e necessità di incremento della popolazione. Indicativo perché è l’unico riferimento, sia pur indiretto, alle donne che evidentemente dal ciclismo “popolare” sono escluse, così come da tanto altro, nonostante il contributo dato alla Resistenza e all’economia italiana in tempo di guerra.